-
Piccole grandi donne di Romagna
- Valentina Golfieri
- Renata Spinardi
- Pierina Cenni
-
Lettera 22 - Le pagine di don Piergiorgio
-
Ricette
-
Personaggi
-
Viserba
-
Tradizioni
-
Dialetto
-
I miei preferiti
Rimini
-
Associazioni
-
Informazione online
-
Link amici
-
Link sponsor
Ma il dialetto non va a scuola
articolo di Franco Loi (Il Sole 24 Ore, domenica 16 settembre 2007)Dialetto è una bella antica parola. Ha a che fare con la dialettica e con l’oralità. Dialettica significa dialogo e confronto, dialogo dell’individuo con se stesso e con gli altri uomini, confronto con Dio o il mistero delle cose, la società, circolarità della parola in una comunità; l’oralità è invece scambio in un reciproco appartenere, conservazione di una memoria, racconto delle vicende del vivere, dei sogni, delle fantasie popolari, osservazione e conoscenze acquisite nel lavoro.
Il dialetto comporta nella sua origine un’aderenza completa dell’uomo, anima e corpo. E’ una vera e propria lingua. Ed è per questo che il fondatore della linguistica, Graziadio Ascoli e più tardi il De Saussure, hanno precisato che “possono avere statuto di lingua soltanto le lingue orali” o dialetti, mentre le lingue nazionali o sovranazionali sono astrazioni politiche. Se poi consideriamo la lingua nel suo etimo più antico, ha significato di leccare, qualcosa che ha attinenza con l’assaporare e, se si pensa che la parola sapienza deriva appunto dal sapore delle cose, vediamo la connessione tra conoscenza ed esperienza corporea. Nominare le cose, dice Genesi, nell’assegnare all’uomo questo compito. Ma come si può nominare le cose, se non praticandole, se non lavorando e vivendo nel corpo delle cose? In questo senso la parola conoscere viene usata ampiamente nella Bibbia nel senso di fare all’amore. Per nominare le cose bisogna farci l’amore assieme.
E veniamo alla politica. In Italia, fin dall’Unità (1870) si è posto il problema di una lingua nazionale; e allora il 97,7% degli italiani parlava le varie lingue regionali. Non si può certo ridiscutere qui l’opportunità di questa scelta. Ma da sempre si è discusso il criterio con cui si è voluto imporre agli italiani la lingua nazionale. Fin da allora, e anche in precedenza uomini come l’Ascoli, Carlo Cattaneo, Giovanni Ferrari, Melchiorre Gioia, e in genere gli uomini più illuminati del nostro Risorgimento avevano proposto di insegnare contemporaneamente i dialetti nelle scuole.
Due erano i motivi fondamentali: da una parte aiutare la gente a comprendere più profondamente l’italiano, dall’altra immettere la ricchezza delle lingue parlate nel tessuto della lingua nazionale. Naturalmente, come succede spesso in Italia, il provvedimento più semplicistico fu quello di imporre l’italiano, una presunta lingua media fiorentina inesistente, e di affossare le lingue partlate dagli italiani. Si fece di più quando fu istituita la scuola media, accessibile alle classi popolari, si vietò l’uso di ogni dialetto. La lingua nazionale divenne un tramite di discrimine sociale, culturale e politico. Tutto questo lo ricordo sommariamente qui, non per una sorta di revanscismo oppositivo alla lingua nazionale. Amo l’italiano, ho sempre parlato italiano a casa e fuori, salvo nel periodo della mia adolescenza. Ma mi sembra opportuno far divulgare un po’ di storia inerente lingue e dialetti. Persino Leopardi, nello Zibaldone, raccomanda ai poeti “l’ascolto del popolo quando parla perché più vicino alla natura e privo di logica”, e del resto tutta la grande narrativa italiana ha sempre attinto a piene mani dai vari dialetti, a cominciare da Verga per finire con Fenoglio e Pavese.
Ma dico che mi sembra inutile insegnare oggi i dialetti nelle scuole. Siamo in un’epoca che vede persino l’italiano decadere nell’uso dei giovani, e ho presente l’esperienza dell’Irlanda dove l’insegnamento del gaelico nelle scuole non ha impedito che gli irlandesi parlassero l’odiato inglese.
Questa è un’epoca di profondi cambiamenti e di vaste commistioni etniche. Certo i costumi hanno sempre contato e contano più delle leggi. Certo fa un certo effetto a Milano ascoltare senegalesi e cinesi parlare milanese, mentre i milanesi si sforzano di parlare italiano, e i parlanti italiano cercano di parlare l’inglese.
Dall’altra parte, fa anche effetto che ancora oggi, malgrado il lavoro compiuto nel secondo Novecento da illustri critici e linguisti, nell’affrontare la letteratura italiana, salvo poche isole illuminate dentro e fuori la scuola, ci si premura di tener separate le opere in lingua nazionale dalle opere in dialetto, quasi che una visione unitaria della cultura fosse nociva dell’Unità nazionale.
Non è un caso che la querelle lingua-dialetti, e la questione del tutto nuova di un decadimento dell’italiano, emergano ai nostri giorni come non fosserro passati quasi 150 anni della nostra storia. E’ il segno di una malattia congenita nella società e nella politica italiana, ma è qualcosa che riguarda soprattutto le classi culturali italiane, che, come ha scritto Giacomo Noventa (pesudonimo di Giacomo Ca’ Zorzi n. 1898, m. 1960, poeta e saggista.) “non credono di solito all’esistenza di una cultura sotterranea. Non credono di solito che esistano in mezzo al popolo uomini intelligenti almeno come i più intelligenti fra noi, e uomini consapevolmente eroici almeno come i più consapevolmente eroici fra noi. In questo scetticismo, in questa boria patriottica, in questo complesso di superiorità verso il popolo italiano è l’origine dei nostri errori e dei nostri rischi.”.
Sull’argomento, segnalo un’interessante intervista a Franco Loi.
Torna Su
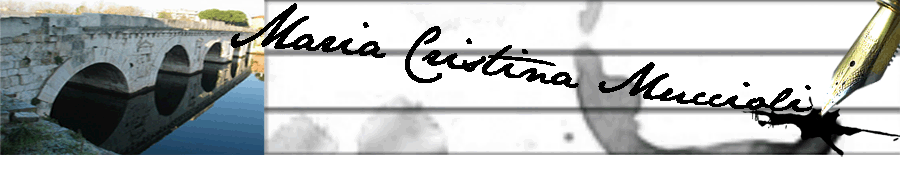

![email: mcmuccioli [at] yahoo.it](http://www.cristella.it/mail.gif) - Tutti i diritti riservati.
- Tutti i diritti riservati.