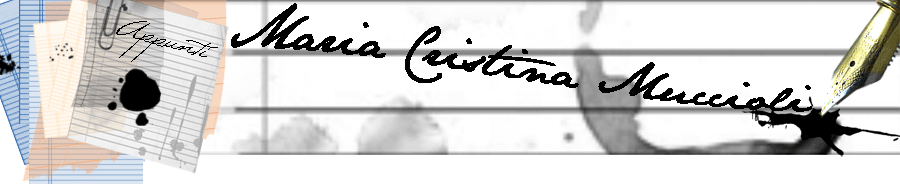Mi comunica Riccarda Casadei, figlia di Secondo Casadei, che domani 5 agosto alle ore 23,30, su Raiuno andrà in onda uno Speciale Tg1 dal titolo Il popolo del liscio. Un reportage sul mondo del ballo in Romagna, delle orchestre e di tutta la gente che ama questo genere.
Riccarda è una signora amabile, che ho conosciuto di persona quando al Museo della Città di Rimini venne celebrato con una mostra il 50° anniversario di Romagna mia, la canzone che fece conoscere suo padre come Il re del liscio. Ci siamo poi incontrate ancora. L’ultima volta a San Mauro Pascoli per la presentazione del libro di Franca Fabbri, di cui ho già scritto.
Oltre ad una sorta di sorellanza dovuta all’amore per dialetto e tradizione romagnola, che definirei “storica”, con Riccarda mi lega anche un dato “geografico”: la casa di Gatteo a Mare dove ho vissuto fino al matrimonio e dove tuttora abita la mia famiglia, è a pochi metri da quella per cui Romagna mia venne scritta.
C’è ancora: all’inizio di via Primo Maggio, nei pressi della stazione ferroviaria, la “Casetta mia” di Secondo Casadei, circondata da un parco-giardino, attira i curiosi perché all’ingresso sono riportati i primi versi della nota canzone.
“Casetta mia, casetta in fiore, tu sei la stella, tu sei l’amore…” Sì, il primo testo presentato dal babbone di Riccarda non era dedicato ad una regione, ma soltanto al piccolo rifugio vacanziero che la famiglia Casadei aveva a Gatteo a Mare, frazione consorella di Sant’Angelo, il paese d’origine di Secondo.
Il responsabile della casa discografica a cui Casadei si presentò, suggerì il nuovo titolo. Per ragioni di marketing, diremmo oggi. Niente di più azzeccato, visto che Romagna mia risulta essere fra le quattro canzoni più suonate nel mondo!
Archivi autore: mcm
Cicciopelatite e morbicella contro i costruttori riminesi
Come già detto in About me, una delle attività preferite di Maria Cristina giornalista è quella di trasformarsi in Regina Cristella (la miglior cura contro la malinconia). In tale veste invento favole e mi piace raccontarle ai bambini andando anche nelle scuole elementari, invitata dagli insegnanti.
La propensione al raccontar storie – che non significa affatto che io creda sempre a quelle che mi raccontano gli altri, specialmente i politici, anzi! – deriva dall’età dell’adolescenza, quando facevo parte nel gruppo Scout di Gatteo a Mare, costola del mitico Cesena 3° di Edo Biasoli.
I miei lupetti, oggi adulti e vaccinati, probabilmente ricordano ancora le storie di Mowgli raccontate attorno ai falò, quando passavamo serate intere del campeggio in montagna a rivivere la vita del branco così come scritta da Kipling…
“Le fiabe – diceva la maestra Carla di Viserba ai suoi ragazzi presentando Cristella all’interno del progetto Psicantropos – aiutano a comprendere la realtà.”
A questo ho pensato quando ho ritrovato, nei file archiviati sotto il titolo “Progetti con le scuole riminesi”, un testo scritto a più mani nel 2001. Ero andata a conoscere i ragazzi della seconda B, alla scuola elementare Decio Raggi di via Matteotti. Entusiasti dell’opportunità di conoscere personalmente Cristella (“Regina felice, perché diventata una vera scrittrice”), si lasciarono coinvolgere nel gioco delle parole libere. In una sorta di brain storming, vennero fuori mille spunti ed idee per un racconto. Gli ingredienti? Loro stessi protagonisti (cercando di nominarli tutti), la maestra, il maestro e la direttrice, la bidella, il vigile davanti alla scuola, il loro quartiere, i cattivi di turno…
Sono passati cinque anni, ma “Il nostro sogno colorato” è ancora attuale. Sarà perché si parlava anche di costruire una fabbrica al posto del Parco Marecchia?
Niente paura: anche se non del tutto impossibile, con l’aria che tira a Rimini e dintorni, tale eventualità venne combattuta dai ragazzi della Seconda B, che fecero scappare i costruttori a colpi di morbicella e cicciopelatite!
Meditate, costruttori riminesi, meditate….
Silvano e Topo Gigio
Ad un anno dalla scomparsa di Silvano Cardellini, giornalista de Il Resto del Carlino, ieri è stato annunciato il progetto di intitolargli una serie di quattro borse di studio per giovani pubblicisti.
Sono coinvolti, oltre al “suo” (e mio) giornale, l’Ordine dei Giornalisti, il Comune, la Provincia, la Fondazione Carim.
Pur sapendo che per carattere Silvano rifuggeva da protagonismi, penso che sia giusto ricordarlo in questo modo.
Nel mio piccolo, avevo auspicato qualcosa del genere un paio di mesi fa, da questo blog e sul quotidiano La Voce, quando il giornalismo riminese perse anche il fotografo Venanzio Raggi.
In questi giorni anche il collega Valerio Lessi, nel suo blog About Rimini, scrive di lui (“Silvano Cardellini, quanto manchi alla tua Rimini”).
Enrico Rotelli, padrone della casa di Kikko, gli aveva dedicato un post l’anno scorso. Invito a leggerlo, insieme al mio commento di allora.
Da parte mia, mi piace ricordarlo con un sorriso. Occhialini sul naso, come sempre, in una delle tante fotografie pubblicate l’anno scorso: dall’immancabile giubbotto multitasche sbuca un quadernetto di scuola dove campeggia, in copertina, il simpatico muso di Topo Gigio.
Un particolare forse sfuggito a molti, che avvicina un maestro ai suoi allievi, noi “piccoli giornalisti”…
Si fa presto, a dire “piada”…
Leggo sul Il Sole 24 Ore di ieri, nell’inserto Centro Nord, un articolo di Andrea Biondi intitolato “Rimini riaccende la polemica sulla ‘vera’ piadina. Lite in Romagna sulla richiesta dell’Igp”.
Chiedere a me, riminese per metà dei miei anni, quale sia la preferita, è come chiedere ad una mamma quale dei due figli ami di più.
Sono nata e cresciuta con la pìda cesenate; svezzata, se così si può dire, con la pièda riminese. Mi piacciono tutte e due. La prima è come il ritorno a casa, alle origini. La seconda mi rammenta che “a metà del cammin…” (nel 1983), col matrimonio e il trasferimento a Viserba ho passato il Rubicone (letteralmente: la mia vecchia casa di Gatteo a Mare sorge a qualche centinaio di metri a nord dello storico fiume).
La diatriba fra pièda e pìda non è nuova e coinvolge riminesi e cesenati/forlivesi: qual è la piadina vera ed originale?
Già il nome non è univoco, appunto. Lo ricordava venerdì scorso, a Castel Sismondo, anche lo scrittore Piero Meldini nell’incontro organizzato dalla Fondazione Carim dal titolo “La piada nei secoli: storia di un cibo povero che ha fatto fortuna”. La nostra versione di pane azzimo prende nomi diversi a seconda del territorio: nella Romagna del sud (Rimini e dintorni) si chiama piada o piadina; più a nord, nel cesenate, prende il nome di pìda (ricordate la canzone “La pìda se parsòt, la pìs un pò ma tòt”?); a Forlì e Ravenna è la pié… La pièda riminese è più larga e sottile (si piega ma non si spezza); la pìda è un po’ più alta di spessore e di superficie più piccola (non si piega, per farcirla si può anche dividere il quadretto in senso trasversale).
Pure negli ingredienti c’è qualche differenza.
Farina, acqua e sale rimangono la base. Per il condimento, la versione storica vorrebbe lo strutto di maiale, sostituibile o integrabile con buon olio extravergine di oliva. Come per quasi tutte le ricette tipiche, poi, anche per la piada si cambia di casa in casa. La mamma e le mie sorelle, arzdore della zona di Cesenatico, mi hanno insegnato ad aggiungere allo strutto un po’ di latte e un pizzico di bicarbonato (o “dose da ciambella”). Mia suocera, riminese doc, usa di preferenza l’olio extravergine e non mette mai il bicarbonato. Il sale va sciolto nel pentolino dell’acqua (che va solo riscaldata, non bollita!). In ogni caso l’impasto va lasciato riposare un po’, anche solo mezz’ora, prima di procedere al lavoro di matterello. La fase della cottura – indizio importante per chi non è romagnolo e non lo ha mai visto fare in diretta – richiede una teglia (o testo) di terracotta o di ghisa posta su fuoco vivace (va bene anche una piastra di ferro pesante). Perché la piada deve cuocere in fretta, qualche minuto per parte, e vuol’essere rigirata e punzecchiata di tanto in tanto con una forchetta o un coltello a lama piatta.
Per chi volesse approfondire, su wikipedia, alla voce piadina, c’è una descrizione piuttosto completa.
Qui, invece, si può leggere un trattato di Piero Meldini, dal libro di Graziano Pozzetto “La piadina romagnola tradizionale” (Panozzo editore 2005)
Buona lettura e… buon appetito!
La Sacramora e le altre acque di Viserba
In bicicletta o in macchina – in ogni caso stando attenta al caos del traffico viserbese ancora più pericoloso per il restringimento della strada – ci passo davanti almeno due volte al giorno. E ogni volta penso al degrado, all’abbandono, al menefreghismo di chi dice “non è di nostra competenza, spetta ad altri”.
E’ la Fonte della Sacramora, che con la sua acqua sempre fresca e la sua importante storia, è una delle più antiche e rinomate della Romagna.
Ricordo, da bambina, quando con lo zio Guerrino partivamo in macchina da Cesenatico per venire a fare rifornimento con bottiglioni e taniche di plastica. Si partiva all’alba o al tramonto, perché c’era sempre fila e quelle erano le ore più tranquille. Al babbo quell’acqua era stata consigliata da un noto medico di Bologna per risolvere il problema dei calcoli renali. Funzionava!
L’abitudine, poi, fece sì che il tragitto da Cesenatico-Gatteo a Mare verso Viserba diventasse una cosa naturale, un appuntamento settimanale da non mancare. Mai avrei pensato, allora, che la zona Sacramora sarebbe diventata mia, nel senso che ci vivo da quasi venticinque anni.
Qualche giorno fa, parlando col presidente del Quartiere 5 Fabio Betti, è stata rispolverata l’idea di cominciare a proporre seriamente un progetto di riqualificazione della Fonte e di alcuni altri siti che in passato facevano di Viserba la Regina delle Acque. “Ne riparleremo – ha detto Betti – dopo l’estate, proponendo qualcosa di serio”.
Speriamo, sarebbe ora!
Intanto, da parte mia, sfodero le armi di cui dispongo: su Il Resto del Carlino del 13 luglio 2007 è stato pubblicato un mio articolo sull’argomento, che si può leggere anche in Romagna e dintorni di Cristella.it, nella sua versione originale.
La ragazza in abito bianco della seconda foto, risalente alla metà degli anni Cinquanta, è Malvina (nonna del webmaster Dora, mamma di mio marito Paolo).