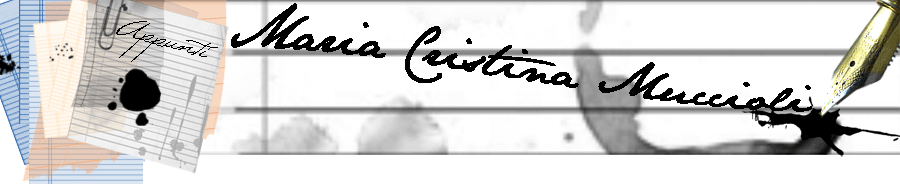Non sarò originale, ma in questa giornata di vigilia sono stata indaffarata, come penso la maggior parte delle donne italiane, nei preparativi culinari per il Natale. Quindi, mi vorrete scusare se, semplicemente, copio-incollo quanto scritto un anno fa. Il rito dei cappelletti s’è ripetuto anche oggi pomeriggio. Tale e quale. Come chissà quante volte in passato…
Buon Natale dalla Romagna!
“Mi siedo al computer solo ora, dopo un pomeriggio in cucina. (…)
Quello della preparazione dei cappelletti è un rito “nostro”. Sì, perché per tradizione si tratta di un lavoro collettivo: la suocera, la nuora (cioè la sottoscritta) e la nipote mezzo-romana che ha nostalgie culinarie romagnole. Un pomeriggio intero a tirare la sfoglia, tagliarla in quadratini, riempirla col “composto”, richiuderla e formare file ordinate di cappelletti sui vassoi infarinati.
Calcolandone una ventina a testa e tenendo presente che a tavola saremo undici, abbiamo preparato la bellezza di 300 cappelletti… Si sa come vanno queste cose: meglio stare abbondanti!
E’ tradizione, in Romagna, che la vigilia di Natale la famiglia si ritrovi per preparare questo tipo di pasta. Ognuno fa qualcosa. E, come succede sempre con le preparazioni tipiche, le ricette, seppur simili, sono differenti da famiglia in famiglia. Quelli che abbiamo preparati oggi, ad esempio, sono i cappelletti della Romagna del sud, col ripieno di carne macinata e formaggio grattugiato, più somiglianti ai tortellini bolognesi.
Quelli della mia infanzia, invece, sono più tipici della zona di Cesena e del Rubicone: più morbidi, col ripieno di formaggi, a cui si aggiunge solo una piccola parte di carne (solitamente petto di cappone). Sono i cappelletti della mia mamma, che li faceva seguendo la ricetta di Pellegrino Artusi.
Il mio “Buon Natale” ai lettori passa quindi attraverso questo piatto della tradizione, così come lo racconta il gastronomo di Forlimpopoli.
Peccato che attraverso Internet non si possano ancora inviare profumi e sapori. Chissà, forse in un futuro neanche tanto lontano questo sarà possibile… Intanto, godetevi la lettura in “stile Artusi”.

Da “La Scienza in Cucina e l’Arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi
Ricetta n. 7 – CAPPELLETTI ALL’USO DI ROMAGNA
Sono così chiamati per la loro forma a cappello. Ecco il modo più semplice di farli onde riescano meno gravi allo stomaco.
Ricotta, oppure metà ricotta e metà cacio raviggiolo, grammi 180.
Mezzo petto di cappone cotto nel burro, condito con sale e pepe, e tritato fine fine colla lunetta.
Parmigiano grattato, grammi 30.
Uova, uno intero e un rosso.
Odore di noce moscata, poche spezie, scorza di limone a chi piace.
Un pizzico di sale.
Assaggiate il composto per poterlo al caso correggere, perché gl’ingredienti non corrispondono sempre a un modo. Mancando il petto di cappone, supplite con grammi 100 di magro di maiale nella lombata, cotto e condizionato nella stessa maniera.
Se la ricotta o il raviggiolo fossero troppo morbidi, lasciate addietro la chiara d’uovo oppure aggiungete un altro rosso se il composto riescisse troppo sodo. Per chiuderlo fate una sfoglia piuttosto tenera di farina spenta con sole uova servendovi anche di qualche chiara rimasta, e tagliatela con un disco rotondo della grandezza come quello segnato. Ponete il composto in mezzo ai dischi e piegateli in due formando così una mezza luna; poi prendete le due estremità della medesima, riunitele insieme ed avrete il cappelletto compito.
Se la sfoglia vi si risecca fra mano, bagnate, con un dito intinto nell’acqua, gli orli dei dischi. Questa minestra per rendersi più grata al gusto richiede il brodo di cappone; di quel rimminchionito animale che per sua bontà si offre nella solennità di Natale in olocausto agli uomini. Cuocete dunque i cappelletti nel suo brodo come si usa in Romagna, ove trovereste nel citato giorno degli eroi che si vantano di averne mangiati cento; ma c’è il caso però di crepare, come avvenne ad un mio conoscente. A un mangiatore discreto bastano due dozzine.