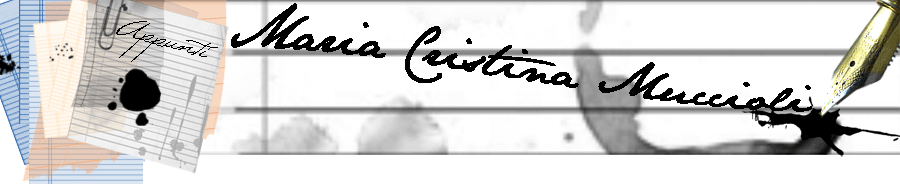Attenzione, mogli e mariti in odor di tradimento, a passare dalle parti di Santarcangelo, vicino a Rimini, tra oggi e l’undici novembre.
O, meglio, ci si può andare, anche perché la cittadina è animata dalla Fiera di San Martino, una delle sagre più antiche della Romagna (qui si può leggere il programma), ma è consigliabile non passare sotto l’Arco Ganganelli, nell’omonima piazza.
Lorenzo Ganganelli, santarcangiolese, venne eletto al Soglio Pontificio col nome di Clemente XIV e passò alla storia per avere soppresso, nel 1773, i Gesuiti e per aver proibito l’evirazione dei ‘castrati’ destinati al Coro della Cappella Sistina come ‘voci bianche’ (guadagnandosi così l’appellativo di Defensor Castrati).
Nella luce del grande arco che la città gli dedicò, ogni anno, per San Martino, viene appeso un paio di corna immense, adornate con le grandi nappe rosse e blu che i contadini usavano contro i sortilegi. Chi, uomo o donna, passando sotto a tali corna dovesse farle oscillare anche solo leggermente, sarà indicato come “becco” ed esposto a pubblica derisione.
Una consolazione per i romagnoli: quella di Santarcangelo non è la sola Fira di bec (Fiera dei becchi) d’Italia, perché evidentemente si tratta di una razza non estinta e presente ad ogni latitutudine. A tal propostito, rimando alla lettura di un simpatico post dell’enciclopedia fatta donna, la blogger genovese Placida Signora.
Per San Martino la notte era ritenuta magica anche perché posta a quaranta giorni dal solstizio d’inverno. Ancora all’inizio di questo nostro secolo in alcune località della Romagna i mariti traditi, venivano chiamati fuori di casa a gran voce da turbe di ragazzacci che suonavano corni o battevano coi sassi su bidoni e lamiere.
Per schernirli ancor di più, si gridava, a mò di filastrocca:
E de’ d’San Martén
tot i bec i va a la fira,
dundèla, dundèla, dundon.
E chi cl’è bec l’è bec,
e chi cl’è bec e’ va a la fira,
dundèla, dundèla, dundon.
E visto che tutte le feste finiscono affogate nel buon vino, anche a Santarcangelo non si scherza: in caso di oscillazione delle corna, i becchi possono consolarsi con qualche bicchiere di ottimo San Giovese, forse anche più amato di San Martino.