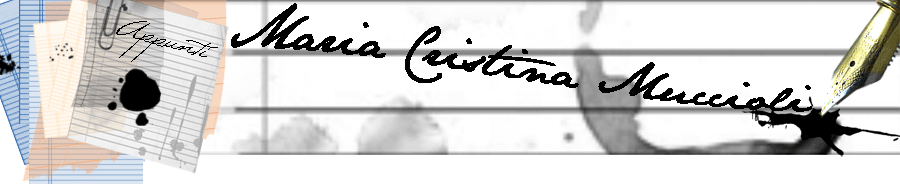Curiosando senza meta, ieri ho scoperto su Youtube diversi spezzoni dei film di Fellini.
Confesso che ho passato qualche ora attaccata al computer a guardarmeli…
Ogni tanto, qualche flash su fatti, personaggi o luoghi riminesi che conosco anche senza i suggerimenti del regista. Di alcuni ho già fatto cenno in post precedenti (per questo ho da poco aggiunto nel blog una “categoria Fellini”).
Sono collegamenti che mi piacciono.
Continuo con l’aiuto del poeta e commediografo Guido Lucchini, che nel suo libro “Raconta Remin, raconta” (Pietroneno Capitani Editore 2004) ci fa conoscere Bilòz, immortalato in Amarcord (in questo trailer del film, al punto 2.40, al passaggio del Rex è quello che chiede agli altri “Com’è? Com’è?”)
Scrive Lucchini:
Bilòz era un suonatore ambulante di organetto, non vedente. Suonava così, senza alcuna logica musicale. Suonava ad orecchio ogni motivo e canzone che sentiva. Erano tradizionali i suoi walzer, perché i andeva a finì in gnint (andavano a finire in niente), tanto è vero che ogni affare non concluso o un amore finito nel nulla erano classificati come “i walzer ad Bilòz”.
Bilòz
E sunèva tal cantéini dla zità
e sunèva se su urganéin
che tnéva a tracòla.
Un sunè senza féin
du che pochi nòti strapazèdi
lis pardéva te vusè
cl’aveva atorna.
L’òcc ciùs, senza piò luce,
forse e durmiva,
forse l’arpasèva tla su meint
i solit pensir
al soliti sperenze,
che pu tòtt us n’andèva finì in gnint
cum’è i su valzer.
Suonava nelle cantine della città
suonava col suo organino
che teneva a tracolla.
Un suonare senza fine
dove poche note strapazzate
si perdevano nel vociare
che aveva attorno.
L’occhio chiuso, senza più luce,
forse dormiva,
forse ripassava nella sua mente
i soliti pensieri,
le solite speranze,
che poi tutto se ne andava a finire in niente
come i suoi valzer.