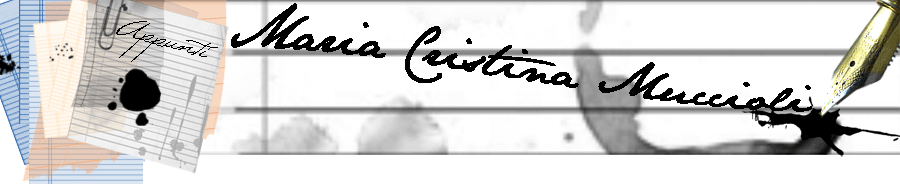Su, su, è un gioco…
Premetto che nonostante gli sforzi del mio webmaster Dora non ho ancora ben capito come funziona un [tag]meme[/tag].
In attesa di capirci qualcosa di più, prometto solennemente e pubblicamente di rispondere al meme fotografico di Liuk (mentre invito i golosi a dare un’occhiata alle ricette inserite nei post più recenti del suo blog Mi arrangio). Risponderò appena avrò imparato come accidenti si fa a postare le fotografie.
Prometto anche la risposta a Shaindel, la gnappetta che dal Venezuela mi invita ad inviare gli auguri di Natale personalizzati attraverso un meme (dove comunque serve aggiungere un’immagine).
Beh, non sarà un meme, questo mio post, ma ci andrà vicino, visto che sto inserendo diversi link a blog amici…
Dopo aver segnalato il poliedrico Luca e la piccola-grande Shaindel, consiglio quindi una visita al blog di Stefano Mina, che cita il mio articolo sulla Corderia di Viserba (anzi, la Scorderia).
Da visitare anche la Casa di kikko ristrutturata, che è solo la cantina del ben più ampio palazzo del giornalista Enrico Rotelli.
Per rimanere in zona, molti avranno saputo che Appunti di viaggio di Michele Marziani ha tirato giù la saracinesca. Non mi azzardo a commentare le motivazioni, anche se vorrei farlo (è un campo minato!), ma io lascio Michele nei miei link preferiti e continuerò a leggerlo. Così come leggo sempre i suoi gustosi articoli su Chiamami Città e i suoi libri sulla cucina.
Segnalo pure Rimini Wikicity made by Gigi, a cui ho passato due articoli su Viserba e che è aperto a nuovi contributi storici secondo la Wiki-philosophy.
E, last but not least, come richiamato nel titolo vorrei passare dalle acque di Viserba a del buon vino Chianti classico: se entro il 10 dicembre voterete “Le mani in pasta di Cristella” (n. 37) attraverso questo post e io dovessi risultare vincitrice, potrei ricevere un regalo natalizio giusto giusto per brindare sotto l’albero.
Votantonio, votantonio!
In caso di vittoria (promessa di politico) realizzerò ovunque parchi, piste ciclabili, parcheggi e asili nido per tutti i bambini, raddoppierò la pensione ai nonni che si impegneranno in attività sportive, culturali e sociali, raddoppierò lo stipendio per ogni figlio in più, obbligherò i creatori di moda a non produrre abiti sotto la taglia 42 e – udite udite – potrei anche invitarvi a bere un bicchiere di Chianti con me nel salone delle feste.
Qui, nella reggia di Cristella, Regno di Sacrabionda.