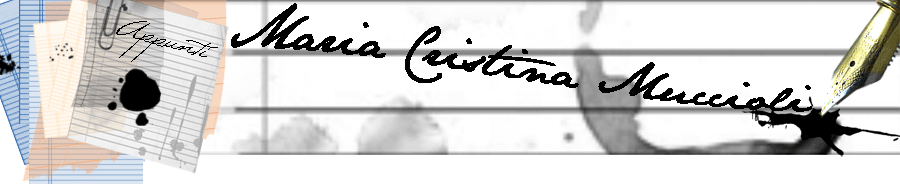La buona cucina è fatta anche di sperimentazioni, giusto?
Era da un po’ di tempo che cercavo la ricetta dei “monfettini in brodo di seppia” che avevo molto apprezzato, qualche mese fa, in uno dei caratteristici ristoranti che guardano in faccia il porto di Cesenatico. In rete ho solo avuto conferma che si tratta di una zuppa tipica di questa zona della Romagna, ma sulla ricetta… niente… mistero.
Quindi mi sono rivolta a Sciura Marinella, la mia super cognata che insieme a mio fratello gestisce l’hotel Sporting, proprio a Cesenatico.
“Maddai, Cri – mi ha detto – è una delle preparazioni più semplici. Che vuoi che sia: si fanno i monfettini, si prepara la seppia, eccetera eccetera…”
Beh, sarà semplice per lei, abituata a trattare i suoi clienti con la stessa cura con cui vizia mio fratello e mio nipote.
Quindi mi sono fatta spiegare per bene i vari passaggi, che ho ricostruito (e documentato con foto) sabato scorso. Sui monfettini, però, ho fatto una variante viserbese, utilizzando i saperi dell’altra enciclopedia vivente che per mia fortuna ho ancora a disposizione, mia suocera Malvina. I monfettini cesenaticensi altro non sono che i monfrigoli. Ah, non sapete cosa sono i monfrigoli? I monfrigoli altro non sono che i battutini. Ancora poco chiaro? Insomma: avete presente la pastina all’uovo della Barilla detta “grattoni”? Ecco, quelli. Eventualmente, comprateli già fatti.
I monfrigoli a casa mia si facevano spesso. Innanzitutto perché molto veloci da preparare, ma anche perché a basso costo. In pratica si tratta di farina e uova, come per la sfoglia delle tagliatelle. L’impasto, però, non viene tirato sottile col matterello, ma tritato con un coltello.
Da Malvina, invece, ho imparato a fare i gnocchetti: una variante dei monfrigoli che aggiunge alla farina bianca un po’ di farina gialla e usa un uovo soltanto.
Ecco dunque le due ricette.
Gnocchetti di polenta della Signora Malvina
Avvertenza: poiché a casa della signora Malvina c’è sempre posto per chi arriva all’ultima ora, le dosi proposte sono sull’abbondante. Il mio consiglio è il seguente: preparate tranquillamente tanti gnocchetti e cucinate solo quelli che secondo voi possono bastare. I rimanenti li stendete in un vassoietto e li congelate per mezzora. Una volta induriti, li raccogliete in un sacchettino (sempre da tenere in freezer), pronti da buttare nel brodo, così congelati, alla prossima occasione.
Ingredienti
4 hg di farina gialla
2 hg di farina bianca
un uovo
un cucchiaino di sale
acqua tiepida (quanto basta)
Preparazione

In una terrina unire le due farine, aggiungere l’uovo, il sale e l’acqua tiepida fino ad ottenere un impasto piuttosto sodo. Farne una palla, coprire con un panno pulito e lasciare riposare almeno un’ora.
Col matterello stendere una sfoglia dello spessore di 3-4 mm (per facilitare questa operazione, spolverare l’impasto con abbondante farina).
Tagliare la sfoglia così ottenuta, prima a striscioline, poi a cubetti.
Far cadere la farina in eccesso raccogliendo i gnocchetti a dita aperte.
Questa pasta povera è molto adatta per le zuppe di legumi (fagioli, ceci), ma anche per la zuppa di seppie. Ottima anche quando viene riproposta il giorno dopo, riscaldata. Un po’ come con i passatelli in brodo…
Zuppa di seppia
Ingredienti
8 hg circa di seppia cruda tagliata a cubetti molto piccoli
½ cipolla tritata
1 spicchio di aglio (schiacciato intero, da togliere alla fine della cottura)
½ bicchiere di vino bianco
½ bicchiere di olio extra vergine di oliva
1 barattolo (anche meno) di salsa di pomodoro
sale, pepe, peperoncino (se piace)
Preparazione
In una pentola versare l’olio, fare imbiondire la cipolla e lo spicchio d’aglio, aggiungere la seppia tritata e farla cuocere, mescolando con un cucchiaio di legno, per 2-3 minuti.
Aggiungere il vino, farlo evaporare.
Aggiungere la salsa, sale, pepe, peperoncino e fare insaporire per 5-10 minuti.
A questo punto aggiungere acqua fino ad ottenere la quantità sufficiente per la vostra zuppa.
Fare sobbollire un altro po’ (non tantissimo: la seppia non vuole cotture prolungate). Assaggiare ed eventualmente aggiustare di sale, gettare i monfettini/monfrigoli/gnocchetti (due cucchiaiate colme per ogni commensale sono una dose da dieta; se avete a tavola gente che richiede il bis, come capita sempre qua da noi, state pure sull’abbondante. Tanto, lo garantisco, questa zuppa è buona anche il giorno dopo!).
Lasciare cuocere per 3 minuti circa.
La casa, a questo punto, sarà già stata invasa dal profumo. I familiari, così richiamati saranno lì, pronti già col cucchiaio in mano.
Se la ricetta vi verrà bene, mandate un saluto a Marinella, Malvina e Cristella.
Av salut!