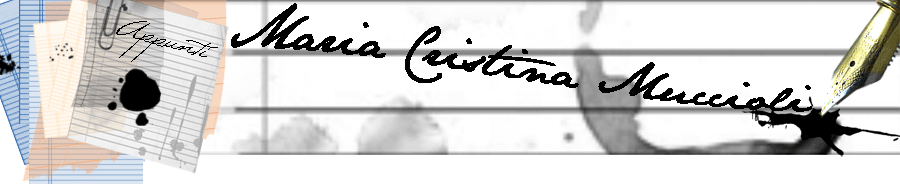Avviso ai naviganti: più che di dizionario, si dovrebbe parlare di glossario. Infatti in queste pagine inserisco, di volta in volta, i termini dialettali che uso nei post. Quasi tutte le definizioni sono tratte dal Dizionario Romagnolo Ragionato di Gianni Quondamatteo.
Almadìra. Così chiamano, a Riccione, quanto il mare, dopo la burrasca, lascia sulla spiaggia. Sono alghe od altri vegetali marini che si ammonticchiano talora in grosse quantità. Raccolta e seccata all’aria e al sole, serviva di combustibile per la povera gente. Nell’almadìra (a Rimini almadéra) sono frammischiati pregadio, scurèzi ad dulféin, caparozi, pisoti e talvolta cannelli e poveracce. A Cattolica dicono: la spiagia l’é pina d’usne.
A m’arcmand. Arcmandè-s: raccomandarsi. A m’arcmand, dice la mamma al figlio che parte soldato. E dice tutto in quel verbo: che fili dritto, che scriva, che si nutra, che indossi la maglia di lana al momento giusto.
Arcurdè-s, ricordare, ricordarsi, rammentare. A m’arcòrd quand ch’a séra burdél… (mi ricordo quand’ero bambino). Mè a m’arcòrd ancora ad cl’eltra guera (io mi ricordo ancora dell’altra guerra). Chi s’arcòrda piò? (chi si ricorda più?). E arcòrdte ad caminè drét! (E ricordati di camminare dritto!), sia come minaccia, sia come paterno conisglio al figliolo che va a lavorare a Milano (nota per Gianluca, il mio lettore romagnol-milanese: ti giuro che nel Dizionario Romagnolo Ragionato di Quondamatteo è proprio scritto così!). T’an t’arcòrd piò quand tcèrte in bulèta? (Non ti ricordi più quand’eri in bolletta?). Molti lo dimenticano e, a ricordarglielo, c’è da farseli nemici.
Arzdora (o azdora) è la reggitrice della casa, alla quale sono affidati precisi compiti nel governo della casa.
Era bene che restasse sempre fra le mura domestiche, perché, dice un detto, “cvand che l’arzdora la va in campagna, l’è piò quel ch’la perd ch’n’è quel ch’la guadagna” (quando la reggitrice va in campagna, è più quello che perde di quello che guadagna).
Bucalòn. Voce usatissima per indicare lo stupidone, il babbeo, e anche l’ingenuo, in senso buono. L’è un pòri bucalòn! (E’ un povero credulone!). Nu fa e’ bucalòn! (Non fare lo sciocco!).
Cantarèla, cantarella. Semplice farina sciolta in acqua e messa sul testo a cuocere; tolta, veniva poi condita con olio e zucchero. Dolce più che semplice e casalingo, che allietava le serate. Fema du cantarèli?, facciamo due cantarelle?. C’è chi completa la ricetta aggiungendovi un po’ di farina di polenta, per renderla più morbida, e un po’ di latte.
Cuchèl. Ornit.: il gabbiano comune (Larus rudibundus), ma anche altre specie di gabbiani. Si dice cuclèssa per il (più grande) gabbiano reale (Larus argentatus) e cucalèt per il gabbianello (Larus minutus) e per le rondini di mare. Tra i nostri cocali, uno dei più grossi chiamato e’ chèga (il caca), ha la pessima abitudine di aggredire i più piccoli per farli vomitare e mangiare quanto espellono. Un proverbio: e’ cuchèl int la maréina (presso o sulla spiaggia), al va al pigre int la staléina, le pecore guadagnano l’ovile (perché il tempo volge al peggio). Fig.: uomo semplicione, come bucalòn. L’è un cuchèl! Cocàlo, scrive Panzini, e cocàl, dice, “è sinonimo di uomo magrissimo, come pure d’uomo stupido, forse per l’immobilità della posa, forse anche perché pessimo a mangiarsi, cibandosi di pesci.”
Faquajòn – chi “fa coglione” un’altra persona, chi imbroglia il prossimo, anche in cosa di minima importanza. L’è un faquajòn, si dice.
Garbéin – garbino, libeccio. E poiché proviene da sud-ovest, questo termine scaturisce dall’arabo garbì, ovvero occidentale, o garb, occidente. Tale autorevole origine si riverbera altresì nello spagnolo, nel provenzale e nel dalmatico (garbin). E’ un vento caldo, afoso, che soffia a raffiche, quasi sempre precursore di pioggia. Garbinàz, quand’è addirittura insopportabile. E’ un vento che dà anche sui nervi, che il meteoropatico preavverte con una diffusa irrequietezza anche molte ore prima: a sént e’ garbéin (sento il garbino), si dice; e, quando soffia, a so ingarbinèd (sono ingarbinato). L’ha e’ garbéin (ha il garbino), ha i nervi tesi. E’ va se garbéin, di chi è di comportamento mutevole. Fin che tira ste garbéin… (fin che tira questo garbino), fin che le cose stan così… Poiché il garbino è vento mutevolissimo, incostante, così si dice di persona che cambi dea, di voltagabbana: t’è la faza cume e’ garbéin (hai la faccia come il garbino) o t’fé tòtt al fazi cume e’ garbéin (fai tutte le facce come il garbino). In campagna: se garbéin e’ bòl e’ véin (col garbino bolle il vino) e con questo vento non si travasa il vino e non si “smette” il baghino (il maiale). Foriero, abbiamo detto, di tempo cattivo: siròc e’ garbéin, dicono infatti i marinai. D’estate, soprattutto, il garbino precede lo scirocco e l’immancabile pioggia. Di qui il modo di dire campagnolo: e’ garbéin en mèt sò e’ lèt a maréina (il garbino non mette su il letto in mare), non si ferma, cioè, ma ritorna indietro sotto forma d’altro vento e provoca guai; si dice anche adès e’ va zò e’ garbéin, l’è quand che torna indré! (adesso va giù il garbino, è quando torna indietro!). Sempre in campagna, per chi ha i capelli in disordine, o gli abiti, si dice: l’è rufid cum per e’ garbéin (è arruffato che mi sembra il garbino). Garbéin s-cèt (garbino schietto) o garbéin frèid (garbino “marcio”), quando non vi sono dubbi di sorta.
Gnara. Le locuzioni la è gnara, la s’fa gnara esprimono una situazione o un momento duri, difficili, critici. Anche la j è gnèra. La terra difficile a lavorarsi, è pure gnara; e così di un inverno che si preannunci cattivo, pesante per le conseguenze, si può dire quest l’è un’invernèda ch’la s’fa gnara!
Impajèda – la puerpera è l’impajèda. Nelle “Relazioni dei parroci del dipartimento del Rubicone, al podestà di Forlì (1811), c’è l’espressione a j’ò la moi int’la paja (ho la moglie nella paglia), che il marito pronunciava quando la moglie aveva partorito. Mentre a j’ò la moi in s’l’aròla (sull’arola) era detto quando la donna avvertiva le prime doglie. Alle prime doglie la donna sedeva davanti al focolare, coi piedi sull’arola, appoggiandosi alla conocchia. Impajèda era anche il pranzo in occasione del battesimo. Andém da l’impajèda (andiamo a trovare la puerpera) e le si portava in dono una gallina per fare un buon brodo, uova fresche, zucchero, caffè, ciambella. La prima uscita della puerpera era dedicata alla chiesa per l’offerta alla Madonna di un mazzo di candele.
Infézna. Sembianza, aspetto, immagine: le caratteristiche che contraddistinguono un volto, una persona. Avé l’infézna, averne l’aspetto, le sembianze; l’ha l’infézna de su pòri ba, è la copia di suo padre, è tutto suo padre.
Te d’ dis ch’l’è un tòc d’putèna? La m’aveva un pò d’infézna! Dici che era una puttana? Mi pareva che ne avesse l’aspetto! Avé ‘na brotta infézna, avere una brutta cera. Di uno che capisce poco: l’ha l’infézna de sumar (ha l’aspetto del somaro). Non mi ha l’aria, non ne ha l’aspetto, si traducono con un m’ha l’infézna!
Invurnìd. Stordito, intontito, istupidito, sciocco, tonto, tardo. In molti casi senza commiserazione alcuna, ma con un pizzico di rabbia, di cattiveria. Sa sit invurnit oz? (Sei invornito, oggi?) dici quando trovi un lavoro malfatto. Se gli autori sono più d’uno, invece, J è na squedra d’invurnìd! (Sono una squadra di invorniti). Di una persona anziana dici: ormai l’è bèla dvènt invurnìd (Ormai è quasi diventato un invornito).”
Luloun. Nel dialetto ravennate del sec. XVII valeva, “uomo senza cervello”. A Rimini e’ luloun è un po’ e’ bucalòn: chi gioca con bambini più piccoli di lui, chi si muove bambinescamente.