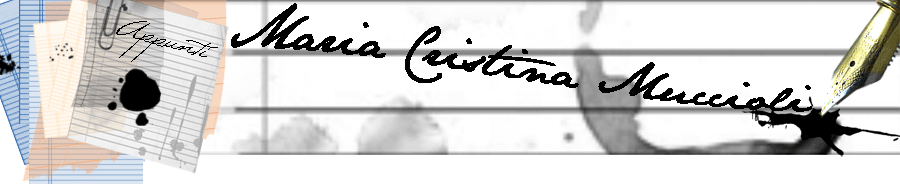“Adesso taglio la torta e me la mangio”.
Tonino Guerra, oggi
pomeriggio, ha concluso così il suo discorso ai concittadini di Santarcangelo di Romagna, accorsi numerosi per festeggiare i suoi 88 anni.
Fra il pubblico c’erano pure diversi ospiti dalla Russia, il paese della moglie Lora, fra cui importanti attori e registi di teatro (anche il grande Yuri Liubimov). Giunti appositamente per i festeggiamenti dedicati al poeta, che proseguiranno domani a Pennabilli, la cittadina del Montefeltro nel quale Tonino vive da diversi anni.
E’ stato molto emozionante seguire il corteo che si era formato per le strade di Santarcangelo e che si spostava al suono di una Marching Band.
Dal parco dove l’Amministrazione Comunale ha posto due “bitte” accanto alla fontana disegnata dal poeta (“il nostro regalo, visto che lui ha sempre detto che siamo come un porto di mare”, ha detto il sindaco Vannoni), accompagnati da un’amazzone biancovestita su cavallo altrettanto candido (che pareva uscita da una scena dei tanti film sceneggiati da Tonino), ci si è portati sotto i portici delle Beccherie.
Sul percorso, appese alle finestre e ai balconi, alcune delle tele create in collaborazione con l’Antica Stamperia Pascucci di Gambettola: disegni di farfalle, bambole, Madonne usciti dalla fantasia di Tonino Guerra ed elaborati con l’antica tecnica della stampa a ruggine dagli artigiani gambettolesi. Queste tele negli ultimi anni sono state protagoniste di mostre molto apprezzate ed hanno ormai fatto il giro del mondo.
“La bellezza ci salverà”, questa una delle frasi che hanno caratterizzato il successivo discorso del poeta.
“In Italia abbiamo ‘la’ bellezza: basta questo a far venire la gente. Da noi ci si sente in famiglia. Il popolo italiano ‘fa star bene’. Ma dobbiamo abbellire ancora, più che si può: i ristoranti, gli alberghi, le città. Dobbiamo porre attenzione alla luce, che in certi momenti deve avere un altro sapore. Dobbiamo dare valore agli artigiani…”
E, riferendosi a Santarcangelo: “Questa città avrà un viaggio bellissimo. Come luogo dove si può fare tenerezza con l’arte.”
Guerra ha anche ricordato diversi aneddoti riferiti alla sua amicizia e alla collaborazione con Federico Fellini, con De Sica e Mastroianni. Ma anche gli incontri con due Presidenti della Repubblica, Ciampi e Napolitano, che gli hanno inviato telegrammi di auguri letti durante la festa.
Mi sono sbizzarrita a scattare fotografie, oggi. Non sono certo di buona qualità, ma un’idea dell’atmosfera la possono dare, no?
Quest’ultima, che stavo per cancellare perché mi pareva “sbagliata”, l’ho salvata in corner. Mi pare rappresentare meglio delle altre la giornata di oggi: la tela disegnata da Tonino alla finestra, la ragazzina (una burdèla) sorridente, truccata e travestita con colori da clown, che porge palloncini.
E, nell’angolo, la bicicletta. Che fa tanto Romagna.