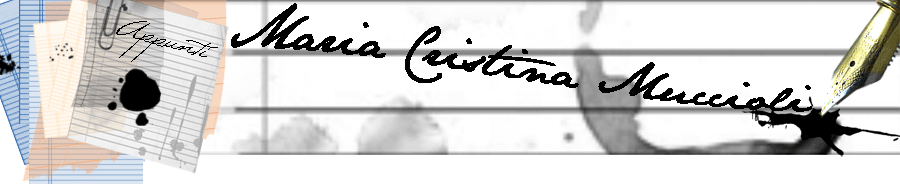Chi frequenta questo blog e la sua autrice sa che Cristella e il Re consorte sono attivi da diversi anni, come volontari, all’interno della dinamica realtà dello Ior, l’Istituto Oncologico Romagnolo.
“Perché si diventa volontari? – ci viene chiesto spesso – Chi ve lo fa fare, di ‘perdere’ del tempo a vendere azalee, organizzare eventi, impegnarvi per la promozione e l’informazione quando potreste andare a spasso per i fatti vostri?”
Il punto è proprio questo: anche se non per esperienza direttissima (chi non ha avuto in famiglia un caso di malattia grave?), tutta l’attività di promozione e informazione che sia possibile fare in questo campo è un “fatto nostro”, eccome!
Proprio in questi giorni sto anche curando l’uscita di RiminiAil Notizie, il periodico dell’Ail (Associazione contro le Leucemie, Sezione di Rimini). Un’altra realtà locale che rappresenta un fiore all’occhiello per il supporto che dà alla macchina della sanità pubblica.
Sono amica dell’Arop, Associazione Riminese Oncologia Pediatrica, fondata, tra gli altri, da genitori che hanno avuto bambini con malattie oncologiche.
E’ un mondo con cui di solito si viene a contatto all’improvviso, incontri che non chiedi, tegole che arrivano in testa. Nello sbandamento e disorientamento dei malati e delle loro famiglie il ruolo delle realtà associative come queste è fondamentale, prezioso, insostituibile.
Forse la Romagna è un’isola felice, in questo senso. E quando scrivo questo penso alla blogger Anonima Mente, che non ha mai rivelato da dove scrive, ma racconta esperienze personali di abbandono sanitario specificando solo che sono vissute in una regione del Sud Italia.
“I have a dream”: quando compro un’azalea della ricerca per 12 euro, immagino che quei soldi, proprio quei 12 euro, saranno gli stessi che domani o dopodomani serviranno a finanziare con una borsa di studio un’ora di ricerca scientifica. La stessa ora in cui un giovane medico o biologo, forse oggi ancora sui banchi di liceo, scoprirà la cura risolutiva per tumori e leucemie.
“I have a dream”: che la buona sanità possa varcare i confini di poche regioni e andare oltre, in tutt’Italia, in Europa, nei paesi più sperduti del globo. E, chissà, è forse proprio là, nel Congo martoriato dalle guerre, in India, in Cina, in Ucraina, che si nasconde il “mio” ricercatore, quello che aspetta i miei 12 euro.
Confesso che questo post è scritto di getto e senza alcuna premeditazione: mi è stato ispirato da una “lettera al direttore” apparsa qualche minuto fa sul quotidiano on-line Newsrimini.it.
E’ la storia vera di un giovane assessore della città di Rimini, mio conoscente, papà di 7 figli, uno dei quali caro amico ed ex compagno di scuola di una delle mie figliole.
Stefano Vitali e la sua testimonianza: leggete anche voi! E sorridete con lui e con Cristella.
Un abbraccio a Stefano, un abbraccio a Mentina, un abbraccio a Princy.
Un grazie alla sanità riminese, allo Ior, a RiminiAil, all’Arop.