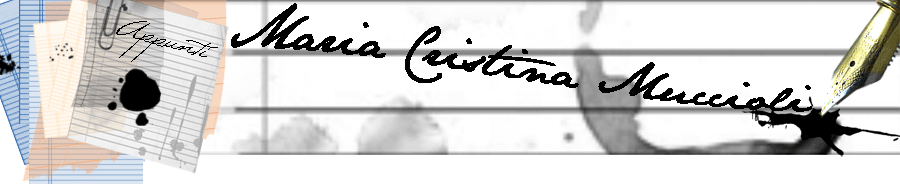Giuliano Bonizzato è un noto avvocato riminese che ama scrivere racconti legati alla storia e alla cultura del territorio in cui vive. Sul quotidiano La Voce tiene un’interessante rubrica intitolata “Cronache Malatestiane”.
Domenica scorsa, 23 marzo, il titolo attira subito la mia attenzione di dialettofila: “Un ‘t’amaz’ non si nega a nessuno”.
E l’articolo non delude le aspettative…
Scrive, Bonizzato, che la sua prima difesa penale aveva a che fare con questa diffusa espressione dialettale.
Il suo cliente era imputato del reato previsto e punito dall’art. 612 del codice penale, per aver minacciato di morte il proprio vicino con la frase “Me ma té a’ t’amaz!” (Io, a te, ti ammazzo!).
L’imputato negava l’addebito, pur ammettendo di aver avuto col vicino una vivace discussione.
Bonizzato racconta con grande ironia le peripezie occorse per andare ad ascoltare a domicilio, in un paesino sperduto fra le montagne dell’entroterra riminese, la madre novantaseienne ed inferma del minacciato, unica testimone del fatto. Col novello avvocato, il Pretore, il Pubblico Ministero e il Cancelliere.
“L’è vera l’è vera, sgnòr Pretòr! E’ mi fiol l’era ma la finestra, lò l’è passè d’-ciota… i a cminzé a ragnè cum e solit e lò u j a dét: mé ma té a’ t’amaz… mé ma té a’ t’amaz…L’è vera, l’é vera!” (E’ vero, è vero, signor Pretore! Mio figlio era alla finestra, lui è passato di sotto, hanno cominciato a litigare come al solito e lui gli ha detto: io a te ti ammazzo, io a te ti ammazzo… E’ vero, è vero!).
Al processo il giovane avvocato, forte dell’autorità di chi sul dialetto romagnolo aveva passato una vita, sostenne che dalle nostre parti un “t’amaz” non si nega a nessuno. Che il termine rappresenta quasi un innocuo intercalare. Che esso non può essere in ogni caso considerato tale da indurre turbamento psichico grave nel soggetto passivo, soprattutto nel contesto di una sia pur accesa discussione tra vicini…
Il Pretore accolse la tesi di Bonizzato e prosciolse l’imputato per difetto di querela.
Ed è proprio così: ci sono delle frasi, nel nostro intercalare, che tradotte letteralmente in italiano farebbero venire i brividi. Un altro esempio?
“Ch’u t’avnèss (o ch’u t’ciapèss) un azidént”, che si traduce con “che ti venga (o che ti prenda) un accidente”.
Nelle stesse occasioni si dice anche “ch’u t’vegna un còlp!” (che ti venga un colpo!).
Sembra strano, ma questi sono saluti fra amici, che magari non si vedevano da vent’anni! Ci si butta le braccia al collo e si è felici di rivedersi sani e salvi.
“Ch’u t’avnéss un azidént!”, dunque, è un complimento. Per dire: “evviva, che piacere ritrovarti!”
Già, perché in Romagna un “t’amaz” e “un azidént” non si negano a nessuno…
Archivi annuali: 2008
Ciambella e uovo benedetto per la colazione di Pasqua
“Non ti ho risposto subito – ha detto – perché sono impegnata in cucina. Sto facendo la ciambella per domani mattina.”
Appena arrivata a casa sua, mi ha accolto il profumo inconfondibile proveniente dal forno e una bella stesa di ciambelle, già pronte, decorate con le codette colorate. In un cestino lì accanto, avvolte in un tovagliolino ricamato, alcune uova sode già benedette in chiesa.
Ciambella e uova benedette: gli ingredienti della tradizionale colazione nel mattino del giorno di Pasqua. Domani, grazie alla disponibilità di Teresa, anch’io ripeterò questo rito del tutto romagnolo.
Per chi volesse approfondire l’argomento, ecco qui di seguito quanto scrive Michele Marziani, giornalista e scrittore esperto in gastronomia del territorio, nel libro “La cucina riminese tra terra e mare” (Panozzo Editore Rimini, 2005).
Buon appetito e… buona Pasqua da Cristella
Scrive Marziani:
Continua a leggere
Fra principesse e regine c’è intesa. Princy e Cristella, unite da… una sana risata
“Se non rido non vivo, perché credo che l’ironia sia l’unico modo per salvarsi dalla disperazione.”
Si conclude con queste parole l’intervista dalla mia amica blogger (e commentatrice fedele) Marina Garaventa, alias Princy60, alias La principessa sul pisello.
Il servizio in questione è andato in onda nell’edizione regionale ligure del TG3 lo scorso 4 marzo, in occasione dell’uscita del libro scritto da Marina insieme a Emilia Tasso intitolato “La vera storia della principessa sul pisello”.
Grazie alla collaborazione tecnica di un altro blogger, l’amico Menphis, chiunque può rivedere e riascoltare l’intervista cliccando qui.
Non vorrei dire di più, se non invitarvi ad ascoltare bene la storia di Marina e, se non l’avete già fatto, andarla a conoscere meglio visitando il suo blog.
Concludo con qualche “parola in libertà”:
propongo di proclamare santo, e subito, chi ha inventato il computer, Internet, i blog e i sintetizzatori vocali;
consiglio tutti gli amici di Cristella di segnarsi l’indirizzo di Princy nei preferiti, tenendo sempre presente che i suoi post e i suoi commenti – oltre che essere di livello culturale, ironico, narrativo “degno di nota” – hanno un peso decisamente diverso da quelli di tutti gli altri blogger (e nessuno si offenda…);
suggerisco (anche a me stessa) di fare propria la filosofia di Marina (“se non rido non vivo”), lasciandoci andare più spesso e volentieri a qualche sana risata…
… che magari quel dolorino alla spalla e al braccio che mi assilla da tempo per l’uso eccessivo del mouse mi passa, vuoi vedere?…
Gli 88 anni di Tonino Guerra. La bellezza ci salverà.
“Adesso taglio la torta e me la mangio”.
Tonino Guerra, oggi
pomeriggio, ha concluso così il suo discorso ai concittadini di Santarcangelo di Romagna, accorsi numerosi per festeggiare i suoi 88 anni.
Fra il pubblico c’erano pure diversi ospiti dalla Russia, il paese della moglie Lora, fra cui importanti attori e registi di teatro (anche il grande Yuri Liubimov). Giunti appositamente per i festeggiamenti dedicati al poeta, che proseguiranno domani a Pennabilli, la cittadina del Montefeltro nel quale Tonino vive da diversi anni.
E’ stato molto emozionante seguire il corteo che si era formato per le strade di Santarcangelo e che si spostava al suono di una Marching Band.
Dal parco dove l’Amministrazione Comunale ha posto due “bitte” accanto alla fontana disegnata dal poeta (“il nostro regalo, visto che lui ha sempre detto che siamo come un porto di mare”, ha detto il sindaco Vannoni), accompagnati da un’amazzone biancovestita su cavallo altrettanto candido (che pareva uscita da una scena dei tanti film sceneggiati da Tonino), ci si è portati sotto i portici delle Beccherie.
Sul percorso, appese alle finestre e ai balconi, alcune delle tele create in collaborazione con l’Antica Stamperia Pascucci di Gambettola: disegni di farfalle, bambole, Madonne usciti dalla fantasia di Tonino Guerra ed elaborati con l’antica tecnica della stampa a ruggine dagli artigiani gambettolesi. Queste tele negli ultimi anni sono state protagoniste di mostre molto apprezzate ed hanno ormai fatto il giro del mondo.
“La bellezza ci salverà”, questa una delle frasi che hanno caratterizzato il successivo discorso del poeta.
“In Italia abbiamo ‘la’ bellezza: basta questo a far venire la gente. Da noi ci si sente in famiglia. Il popolo italiano ‘fa star bene’. Ma dobbiamo abbellire ancora, più che si può: i ristoranti, gli alberghi, le città. Dobbiamo porre attenzione alla luce, che in certi momenti deve avere un altro sapore. Dobbiamo dare valore agli artigiani…”
E, riferendosi a Santarcangelo: “Questa città avrà un viaggio bellissimo. Come luogo dove si può fare tenerezza con l’arte.”
Guerra ha anche ricordato diversi aneddoti riferiti alla sua amicizia e alla collaborazione con Federico Fellini, con De Sica e Mastroianni. Ma anche gli incontri con due Presidenti della Repubblica, Ciampi e Napolitano, che gli hanno inviato telegrammi di auguri letti durante la festa.
Mi sono sbizzarrita a scattare fotografie, oggi. Non sono certo di buona qualità, ma un’idea dell’atmosfera la possono dare, no?
Quest’ultima, che stavo per cancellare perché mi pareva “sbagliata”, l’ho salvata in corner. Mi pare rappresentare meglio delle altre la giornata di oggi: la tela disegnata da Tonino alla finestra, la ragazzina (una burdèla) sorridente, truccata e travestita con colori da clown, che porge palloncini.
E, nell’angolo, la bicicletta. Che fa tanto Romagna.
Focarina, fogheraccia, fugaràza: sempre fuoco (e festa) è…
In tutta la Romagna, e Rimini non fa eccezione, in questo periodo cominciano a vedersi, qua e là, dei mucchi di sterpi e di legna che crescono in altezza di giorno in giorno.
Non solo in aperta campagna: basta uno spiazzo libero dai condomini, una piazza o un cortile di parrocchia. Va di moda, ma non era così fino a qualche anno fa, anche la spiaggia.
Cosa succede?
Come in un film di Fellini si sta preparando il set per una rappresentazione che si ripete da tempo immemorabile: la fogheraccia (o focheraccia) di san Giuseppe, in dialetto riminese “fugaràza”.
La sera del 18 marzo, appena dopo il tramonto, si comincia a sentire odor di fumo e a vedere numerosi fuochi che si accendono, non necessariamente con tempi sincronizzati: c’è chi consuma il rito appena dopo la cena, chi invece ne approfitta per trasformare il tutto in una sorta di barbecue alla romagnola, con salsicce, costine di maiale e l’immancabile sangiovese.
Qui a Viserba – e precisamente proprio davanti alla mia finestra, nello spazio ancora libero di cui scrivevo in un precedente post – viene allestita una fogheraccia che è diventata ormai storica: quella di Bruschi, che già due anni fa era data per spacciata per l’imminente costruzione di qualche palazzo (tanto per cambiare…).
L’annunciato “spegnimento”, però, è stato solo rimandato, visto che quest’anno si accenderà per davvero l’ultima “fogheraccia della falesia”: i lavori della nuova rotonda continuano infatti a pieno ritmo e il mucchio di legna da far ardere è lì, pronto. Più alto degli altri anni, a ricordare che questa volta è formato anche dai tronchi degli alberi che sono stati abbattuti per far posto alla strada e alle nuove costruzioni.
Comunque, la fugaràza è sempre un momento di gazòja (gioia e festa insieme) per grandi e per bambini.
Ricordo quando, a Gatteo a Mare, organizzati in una banda chiassosa andavamo in giro a raccogliere la legna con un carrettino, sotto la regia della “nonna” (quarant’anni fa la Pierina d’e’ Zaqual aveva poco più della mia età di oggi, ma era già “la nonna”, col fazzoletto in testa e la parananza sempre legata in vita).
Da quelle parti per indicare il falò di san Giuseppe si dice fugaréina (focarina), ma la sostanza non cambia: l’agitazione della preparazione, che durava settimane; l’emozione dell’accensione; la gioia nei volti illuminati e scaldati dal fuoco; la malinconia delle ultime scintille che sfuggono ai carboni che rimangono… E la mamma ci richiamava in casa, col fumo che rimaneva ad impregnare l’aria fino al giorno dopo, e anche oltre.
A quei tempi (quarant’anni fa) i fratelli Enrico e Ubaldo Branzanti, miei vicini di casa, scrissero una canzoncina che una mia amichetta cantò al “Festival di casa nostra” (io ero nel coro!).
Ricordo ancora il ritornello gioioso: “La focarina, la focarina, quanti musetti intorno a quel fuoco, coi goccioloni giù per il naso. La focarina, la focarina…”
Chi allora si troverà da queste parti per la prima volta proprio la sera del 18 marzo e sentirà rumore di botti e odore di fumo non abbia paura: non è scoppiata la guerra.
E’ “soltanto” una delle feste più antiche e sentite della Romagna.
Fra le tante descrizioni dei falò di san Giuseppe, trascrivo qui di seguito quella del pluri-citato Gianni Quondamatteo (dal Dizionario Romagnolo Ragionato).
Fugaràza – gran fuoco, falò; focarone.
Alla vigilia di S. Giuseppe, la sera del 18 marzo (un po’ meno il 24 dello stesso mese, alla vigilia della Madonna), si accendono fuochi in tutta la Romagna; e si spara, e si fanno botti di ogni genere. L’ardore, da ragazzi, era tale, che qualche volta ci si dava al furto della legna, al saccheggio e perfino all’abbattimento di alberi. Dopo la fugaràza, dato fondo a tutta la legna, per la Madonna c’era la fugaréina.
G. Pecci: azzandrém anca st’ann al fugarein (accenderemo anche quest’anno le focarine).
Poiché di donna di scarso seno si dice che il falegname S. Giuseppe vi è passato con la pialla, ingraziarsi il santo vuol dire allontanare questo pericolo; di qui il curioso detto la fugaraza grosa la fa crès al tèti (la fogheraccia grossa fa crescere le tette); ergo, reca legna abbondante al falò.
In alcuni posti si dice (alla ragazza con poco seno): t’an è fat i fug ad san Jusèf, e san jusèf u t’a pas la piala (non hai fatto i fuochi a san Giuseppe, e san Giuseppe ti è passato sopra con la pialla).
Al fugarèn ad san Jusèf resistono in tutta la Romagna. Esse costituiscono certo un avanzo di costumi pagani e ne’ è da dimenticare che Marte era, nei tempi primitivi di Roma, il dio della campagna e della vegetazione. Pratella ritiene che con le “focarine” si volesse salutare il Dio Sole, identico, in tempi remoti, al dio Mavors (Marte), dio dell’anno (che cominciava appunto con il mese di marzo) e della primavera. Gaspare Bagli ricorda un bando di Carlo Malatesta, del 1379, che proibiva di festeggiare marzo con fuochi, perché risentivano degli usi pagani.
Un particolare significato, lo ricorda Ovidio, era il salto del falò da parte dei pastori, quando si celebravano in aprile le feste Palilie. E ancora oggi i giovani si cimentano saltando oltre le fiamme. All’inizio, invece, si forma un cerchio di bimbi, con le mani a catena, e una cantilena sale al cielo, facendo pensare ad una misteriosa invocazione alla luna: “Lòna, lòna ad mèrz, una spiga faza un bérc, un bérc e una barcheta, una gheba s’uva sèca, luna, luna di marzo, una spica produca una bica, una bica (mucchio di covoni di grano) e una bichetta, e una cesta d’uva secca.