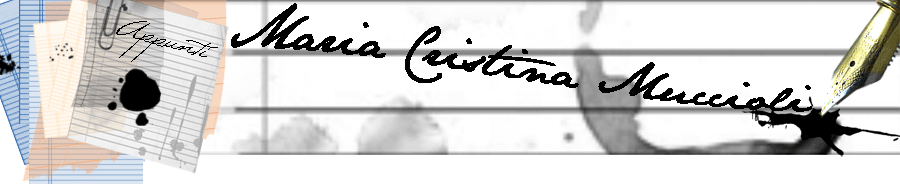In diverse occasioni Federico Fellini ha dichiarato: “Quando penso a Gambettola mi viene sempre in mente Hieronymus Bosch”.

Secondo me non faceva solo riferimento ai volti e ai corpi stonati dipinti dal pittore fiammingo, ma anche all’assonanza del nome con quello del paese di cui era originaria la famiglia del padre Urbano e dove il piccolo Federico passava le estati dell’infanzia, a casa della nonna.
Gambettola, paese dell’entroterra romagnolo situato sulla via Emilia a metà strada fra Savignano sul Rubicone e Cesena, in dialetto non esiste: si è infatti sempre chiamato “E’ Bosch” (il bosco) e così è nominato ancor oggi da chi si esprime in romagnolo.
Urbano Fellini, commerciante di generi alimentari, conobbe la giovane Ida Barbiani a Roma durante un viaggio di lavoro. Dopo varie peripezie i due si fidanzarono e andarono a vivere per un po’ di tempo a Gambettola, nella casa di via Soprarigossa. Solo successivamente la famigliola si trasferì a Rimini, dove Federico nacque. Si potrebbe ragionevolmente affermare, quindi, che Fellini è per metà romano e per metà “d’ E’ Bosch”, riminese d’adozione.
Perché questo discorso sulle origini del Maestro? Innanzitutto perché anche i miei genitori sono originari di quella zona. Il babbo era del 1917 e la mamma del 1923. Fellini del 1920. Mi piace pensare che da bambini, attorno agli anni Venti-Trenta, si siano anche incontrati durante quelle estati campagnole…
Ma uno stimolo mi viene anche dalla notizia, letta il 14 e il 15 marzo sul quotidiano Corriere Romagna, che la Giunta comunale di Gambettola ha deciso che la Casa Fellini, ormai pericolante e qualche anno fa salvata da una sicura demolizione, diventerà un museo del cinema, con annesso un Festival Internazionale del cinema all’aperto.

“Fellini è patrimonio dell’umanità – dicono a Gambettola – e la casa si trova di fianco al più grande parco verde dell’area Rubicone, con 24mila metri quadrati e alcuni servizi, Tra l’altro è adiacente anche al torrente Rigossa, che potrebbe diventare una tappa del percorso della ciclopedonale che da tempo si pensa di fare da mare a collina, diventando punto di riferimento per gli escursionisti a due ruote.”
Certo, ora entra in gioco il progetto e la volontà (leggasi: soldi) di portarlo a termine. Comunque, questa decisione del Comune di Gambettola è esemplare.
Se il paese natìo del padre di Fellini ha questi progetti, cosa dovrebbe fare, in proporzione, la “sua” Rimini? Ogni riferimento alle polemiche più o meno recenti sull’inadeguatezza, agli occhi del mondo, del Museo Fellini di via Oberdan, a Rimini, non è casuale (Gianfranco Angelucci docet). Qualche anno fa la diva Sharon Stone, invitata a Rimini per le Giornate del Pio Manzù, chiese di vedere il Museo Fellini. Arrivata a bordo di una limousine bianca, impiegò solo tre minuti a visitarlo.
“Tutto qua?”, il suo lapidario commento…
Citazione da “La mia Rimini”, di Federico Fellini:
A Gambettola, nell’entroterra romagnolo, ci andavo d’estate. Mia nonna teneva sempre un giunco nelle mani, col quale faceva fare agli uomini certi salti da cartone animato. Insomma, faceva filare gli uomini presi a giornata per lavorare il campo. La mattina si sentivano risatacce e un gran brusìo. Poi, davanti a lei che appariva, quegli uomini violenti assumevano un atteggiamento di rispetto, come in chiesa. La nonna, allora, distribuiva il caffelatte e si informava di tutto. Voleva sentire il fiato di Gnichéla, per scoprire se aveva bevuto la grappa: e questi rideva, dava gomitate al vicino, per il pudore, diventava un bambino.
Mia nonna era come le altre donne romagnole. Una di queste, tutte le sere, andava all’osteria a prendere il marito ubriaco e lo caricava sopra una carriola per condurlo a casa (scena vista nel film I clowns). Lui si chiamava Ciapalòs, che non è un nome greco, ma vuol dire “Prendi l’osso”. Una sera, l’uomo se ne stava con le gambe penzoloni fuori dalla carriola trascinata dalla moglie, in uno stato di beata mortificazione, dopo aver sopportato il dileggio generale. Quella sera, io incontrai gli occhi dell’uomo, sotto il cappellaccio. (…)
Un giorno mi piacerebbe fare un film sui contadini romagnoli: un western senza revolverate, intitolato “Osciadlamadona”. Una bestemmia: ma, come suono, è più bello di “Rasciamon”.