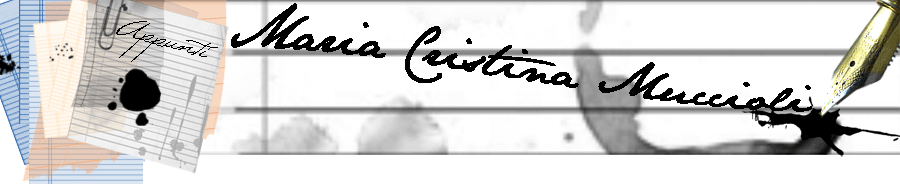Un week end di full immersion nel dialetto.
Oddio, no! Non è proprio il caso di infilare quattro parole inglesi in una frase che ne conta otto in tutto. A cosa sarebbe servita la lezione?
Alòura: “un sàbat e una dménga a mòl t’e’ dialèt”. (allora: un sabato e una domenica a mollo nel dialetto).
Come avevo preannunciato qualche giorno fa, nell’ultimo fine settimana ho partecipato al seminario sulle lingue romagnole tenuto a Bellaria dall’attore Ivano Marescotti.
Per Cristella è stata un’esperienza decisamente piacevole e costruttiva. Gli “allievi” del prof. Marescotti erano, oltre a me, una quindicina di persone provenienti da diverse parti della Romagna. I più giovani sui trent’anni, la più “anziana” un’ex maestra che ci poteva essere mamma (non è fine svelare l’età di una signora).
L’aspetto più curioso delle due mezze giornate passate insieme a discutere di dialetti (a scòrr d’i dialét – notare, nel plurale, l’accento sulla “e”, che diventa acuto – visto che ho imparato le lezioni, prof.?) è stato verificare in presa diretta le differenze fra l’una e l’altra zona: anche nel raggio di qualche chilometro cambiano pronunce e inflessioni. Ma non solo: spesso sono diverse anche le parole che indicano la stessa cosa e persino la costruzione grammaticale delle frasi.
Per esempio: quasi dappertutto la mamma si dice “mà” , mentre nella zona ravennate (quella da cui proviene Marescotti), che tocca anche parte del territorio forlivese e cesenate, si dice “màma”, dove quella “à” che si avvicina ad una “e” viene pronunciata “alla portoghese”.
Fra le tante considerazioni, comunque, alcune certezze (di tutti, non solo di Marescotti).
Primo: il dialetto è – e rimane – una lingua orale e venendo a mancare, un po’ alla volta, la grande risorsa dei vecchi (coloro cioè che ancora pensano e parlano in dialetto) la perderemo.
Secondo: scrivere in dialetto è difficilissimo, sebbene ci siano precise regole di sintassi e grammatica.
Terzo (già detto): i dialetti sono tanti e diversi, spesso identificabili di famiglia in famiglia.
Quarto: fra i poeti che scrivono o hanno scritto in romagnolo, il più grande rimane Raffaello Baldini, di Santarcangelo. “Il più grande poeta italiano degli ultimi decenni” ha scritto di lui un noto critico letterario. Beninteso: il più grande italiano, non il più grande dialettale.
La sua capacità di essere tragico con ironia è la sfumatura che lo contraddistingue più di altre.
Riportare ancora una volta qualcuno dei suoi versi è un piacere.
Un consiglio: la poesia in dialetto va letta a voce alta. “Dài, próva ènca té!”
Mo acsè, dal vólti, quant a tòurn a chèsa,
la sàira, préima d’infilé la cèva,
a sòun, drin drin,
un’arspònd mai niseun.
Ma, così, delle volte, quando torno a casa, la sera, prima d’infilare la chiave, suono, drin, drin, non risponde mai nessuno.